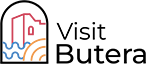La Chiesa Maria Santissima delle Grazie a Butera: Un’Analisi Dettagliata
La Chiesa Maria Santissima delle Grazie di Butera si erge come un notevole esempio di architettura religiosa e un fulcro di profonda devozione all’interno del panorama storico e culturale della regione. Situata in prossimità del castello medievale e sul margine settentrionale della vasta Piazza della Vittoria, con la sua facciata rivolta verso Via Maria Josè, la sua ubicazione centrale ne sottolinea l’importanza storica e il suo ruolo significativo per la comunità locale 1. La vicinanza a un’imponente struttura storica come il castello suggerisce una storia potenzialmente lunga e intrecciata con lo sviluppo stesso di Butera, un aspetto che merita un’esplorazione più approfondita per comprendere appieno le sue origini. La sua inclusione tra gli altri siti notevoli di Butera, come la Chiesa Madre e San Rocco 2, ne consolida ulteriormente lo status di punto di riferimento di interesse sia per i visitatori che per gli abitanti, indicando una rilevanza culturale e, con ogni probabilità, un pregio architettonico o artistico che contribuisce all’identità della città.
- Storia e Origini
Le fonti storiche indicano che l’attuale Chiesa Maria Santissima delle Grazie sorge sul sito di un precedente edificio di culto medievale, dedicato a Sant’Ippolito e affidato ai Cavalieri dell’Ordine del Santo Sepolcro 1. La costruzione della chiesa che possiamo ammirare oggi risale al XVI secolo, segnando una significativa continuità storica del sito come luogo di preghiera e venerazione per la comunità di Butera. Questo cambio di dedicazione da Sant’Ippolito a Maria Santissima delle Grazie rappresenta un punto cruciale nella storia della chiesa, suggerendo un possibile mutamento nelle priorità devozionali locali o un evento storico specifico che portò a questa nuova intitolazione.
All’interno della chiesa, sul lato sinistro verso il coro, si trova un dipinto a olio su tavola risalente al 1556, raffigurante la Madonna del cardellino tra i santi Giovanni Battista e Agata 3. Quest’opera fornisce un collegamento tangibile con la costruzione cinquecentesca della chiesa e testimonia la presenza di attività artistica e devozionale in quel periodo. Un elemento architettonico interessante è la chiave di volta del portale, che reca la data 1416 3. Questa data, rimasta sconosciuta fino a recenti restauri che hanno portato alla luce una caratteristica facciata in pietra, solleva interrogativi sulla cronologia esatta della struttura. Potrebbe indicare una fase costruttiva precedente, forse relativa alla chiesa medievale di Sant’Ippolito, con il portale riutilizzato nella ricostruzione del XVI secolo. In alternativa, potrebbe rappresentare un significativo intervento di ristrutturazione o un’aggiunta a una struttura preesistente del XV secolo, successivamente riedificata nel Cinquecento.
Sebbene non direttamente pertinente alla chiesa di Butera, un’altra Chiesa Maria SS. Delle Grazie, situata a Genzano di Lucania, fu presumibilmente edificata tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo, per poi essere distrutta da un violento terremoto nel 1860 e ricostruita nel 1878 4. Questa informazione, pur riguardando un edificio omonimo in un’altra località, sottolinea la diffusione della dedicazione a Maria Santissima delle Grazie e la vulnerabilità delle strutture religiose ai fenomeni sismici, che spesso hanno segnato la storia di molti edifici sacri in Italia.
Un momento significativo nella storia della Chiesa Maria Santissima delle Grazie di Butera è rappresentato dall’intervento dell’ingegnere Ignazio Margani nel 1896 3. Fu lui a curare il progetto per la sistemazione architettonica e l’abbellimento della chiesa su commissione dell’allora rettore Sac. Gaetano Di Vita. Questo intervento tardo ottocentesco ha indubbiamente plasmato l’aspetto attuale della chiesa, rendendo cruciale distinguere tra gli elementi originali del XVI secolo e le aggiunte e modifiche apportate in questa fase successiva. La storia della chiesa si presenta quindi stratificata, con una preesistenza medievale, una costruzione cinquecentesca e un importante rinnovamento alla fine del XIX secolo. Comprendere questa evoluzione temporale è fondamentale per analizzare con precisione le sue caratteristiche architettoniche e artistiche.
III. Architettura Esterna
La Chiesa Maria Santissima delle Grazie sorge in una posizione di rilievo a Butera, nelle immediate vicinanze del castello medievale, sul lato settentrionale di Piazza della Vittoria, con la sua facciata orientata verso Via Maria Josè 1. La pianta dell’edificio è di tipo longitudinale, una tipologia comune per le chiese cristiane che enfatizza il percorso processionale verso l’altare. Questa collocazione strategica, nel cuore storico e civico della città, sottolinea la sua importanza all’interno del tessuto urbano di Butera.
La facciata principale si affaccia su un sagrato di dimensioni contenute ma funzionale, delimitato a sinistra dalla cancellata di un giardino pubblico e a destra da edifici residenziali 1. Il suo schema compositivo è essenziale e lineare, caratterizzato da una superficie piana con un coronamento che segue l’andamento a due falde del tetto. L’unico elemento di spicco è rappresentato dai conci in pietra arenaria intagliata che incorniciano il portale d’ingresso. Sopra il portale, in asse con esso, si apre una finestra rettangolare priva di cornice. L’intera superficie della facciata è intonacata. L’utilizzo della pietra arenaria locale per il portale conferisce un carattere regionale all’edificio, mentre l’intonacatura potrebbe celare una preesistente lavorazione in pietra o riflettere una scelta estetica successiva, forse risalente alla ristrutturazione del 1896. La semplicità del disegno, definita “essenziale”, potrebbe essere una caratteristica della costruzione originaria del XVI secolo o il risultato di modifiche successive.
I prospetti secondari della chiesa sono in parte adiacenti ad altri edifici; solo il lato meridionale risulta completamente visibile, mentre il lato settentrionale è libero solo nella parte superiore 1. Le elevazioni secondarie visibili sono prive di particolari elementi architettonici, interamente intonacate e presentano due finestre rettangolari per lato nella parte superiore, anch’esse senza cornice. Questa sobrietà suggerisce che l’attenzione architettonica era concentrata principalmente sulla facciata principale, destinata alla vista pubblica, mentre i lati avevano una funzione più utilitaristica, forse a causa della loro limitata visibilità o della contiguità con altre costruzioni.
È importante notare che, secondo alcune fonti, recenti restauri hanno rivelato una caratteristica facciata in pietra 3. Questa informazione contraddice la descrizione di una facciata intonacata fornita da altre fonti, indicando un significativo cambiamento nell’aspetto della chiesa nel corso del tempo. È molto probabile che l’intonacatura sia stata un’aggiunta successiva, forse durante la ristrutturazione del 1896 ad opera di Margani, e che i restauri successivi abbiano mirato a riportare alla luce l’aspetto originario in pietra, riflettendo un cambiamento nelle priorità di conservazione. Questa scoperta evidenzia come l’aspetto esterno della chiesa abbia subito trasformazioni nel corso dei secoli.
Infine, va segnalata l’assenza di descrizioni specifiche riguardanti un campanile (torre campanaria) nei documenti consultati. Questa mancanza di informazioni potrebbe indicare che la chiesa non possiede un campanile di particolare rilievo o che le fonti disponibili non si sono concentrate su questo elemento architettonico. I campanili sono spesso elementi distintivi delle chiese, svolgendo sia una funzione pratica che simbolica, e la loro assenza di menzione potrebbe suggerire che, nel caso della Chiesa Maria Santissima delle Grazie di Butera, non rappresentino una caratteristica architettonica primaria.
- Architettura Interna e Decorazioni
L’interno della Chiesa Maria Santissima delle Grazie si presenta con una singola navata longitudinale che culmina in un presbiterio a pianta quadrata 1. L’edificio è costruito in aderenza ad altre strutture sui lati settentrionale e occidentale. Una piccola porta situata sul lato sinistro della parete di fondo del presbiterio conduce alla sacrestia e, da questa, a un ingresso posteriore. Un’altra porta, posta sul lato destro della navata poco prima dell’arco trionfale, introduce a un salone destinato alle attività pastorali. La semplicità della pianta a navata unica è una scelta architettonica comune per le chiese, focalizzando l’attenzione dei fedeli verso l’altare maggiore e le azioni liturgiche che si svolgono nel presbiterio. La presenza della sacrestia e del salone per le attività pastorali sottolinea il ruolo della chiesa come centro non solo di culto ma anche di aggregazione e servizio per la comunità.
Le pareti laterali della navata sono scandite da colonne che delimitano gli spazi destinati alle cappelle con altari secondari. Originariamente, si contavano tre cappelle per lato, ma attualmente ne è presente solo una per lato 1. Questa riduzione nel numero delle cappelle laterali è un dettaglio significativo che potrebbe riflettere interventi di ristrutturazione, come quello del 1896, o cambiamenti nelle pratiche devozionali nel corso del tempo. La parete di fondo del presbiterio è caratterizzata dalla presenza della macchina d’altare, elemento centrale dello spazio sacro. Le superfici interne sono interamente intonacate, fornendo una base per ulteriori decorazioni, come gli stucchi menzionati in altre fonti. Al di sopra del fregio che corre lungo le pareti, si aprono finestre laterali che, unitamente alla finestra della facciata, permettono alla luce naturale di illuminare l’aula. Sulla controfacciata si trova una cantoria in legno, destinata ad ospitare l’organo a canne, elemento che sottolinea l’importanza della musica nella liturgia della chiesa.
Sia la navata che il presbiterio sono coperti da una volta a botte lunettata 1. Questa tipologia di copertura è un elemento architettonico frequente nelle chiese, in quanto offre sia un sostegno strutturale che una superficie curva adatta a decorazioni. L’intradosso della volta è intonacato e ornato da stucchi, indicando un livello di abbellimento artistico all’interno della chiesa. La struttura del tetto è in legno ed è rivestita da tegole in stile siciliano, i cosiddetti “coppi siciliani”, un elemento architettonico regionale che riflette le tradizioni costruttive e i materiali locali.
La pavimentazione della chiesa è realizzata con lastre di marmo Botticino alternate a corsie di granito 1. Anche le alzate degli scalini del bema, che separa la navata dal presbiterio, sono in granito. L’utilizzo di marmo e granito suggerisce una volontà di impiegare materiali durevoli e di pregio per il pavimento, riflettendo l’importanza della chiesa per la comunità e le risorse investite nella sua realizzazione e manutenzione. Il bema, a sua volta, funge da divisione visiva e simbolica tra l’area destinata ai fedeli e quella riservata al clero e all’altare.
Un’altra fonte conferma la presenza di una singola navata e sottolinea la ricchezza dei fregi interni 3. Questa fonte indica inoltre la presenza di due cappelle per lato, un’informazione che contraddice quanto riportato in precedenza riguardo a una sola cappella per lato. Questa discrepanza potrebbe indicare un cambiamento avvenuto nel tempo o una diversa interpretazione delle fonti. La copertura dell’intero edificio sacro è costituita da una volta a botte ribassata, riccamente decorata con stucchi. Questa descrizione ribadisce la ricchezza delle decorazioni interne, in particolare degli stucchi, suggerendo uno spazio visivamente notevole. L’intervento di Ignazio Margani nel 1896, come precedentemente accennato 3, ha contribuito in modo significativo all’abbellimento della chiesa, e molte delle caratteristiche interne visibili oggi potrebbero risalire a questo periodo.
- Opere d’Arte di Particolare Valore
L’opera d’arte di maggiore rilievo all’interno della Chiesa Maria Santissima delle Grazie è senza dubbio il simulacro della patrona, Maria Santissima delle Grazie, anche conosciuta come Madre delle Grazie 3. Questa venerata effigie è collocata sull’altare maggiore ed è attribuita allo scultore palermitano Vincenzo Genovese. La statua riveste un’importanza sia artistica che religiosa per la comunità di Butera, tanto da essere portata in solenne processione per le vie della città il 2 luglio, giorno della festa patronale. Il suo ruolo centrale nelle celebrazioni annuali ne sottolinea lo status di fulcro della devozione e di simbolo culturale per Butera. L’attribuzione a un artista specifico come Genovese aggiunge valore artistico e contesto storico all’opera.
Un altro manufatto di notevole valore storico e artistico è un dipinto a olio su tavola risalente al 1556 3. Quest’opera raffigura la Madonna del cardellino, iconografia mariana che spesso simboleggia la futura Passione di Cristo, affiancata dalle figure di San Giovanni Battista e Sant’Agata. L’autore di questo dipinto è sconosciuto, ma viene identificato come appartenente alla scuola manierista. La datazione al 1556 suggerisce che l’opera potrebbe essere contemporanea alla costruzione cinquecentesca della chiesa o addirittura antecedente alle ristrutturazioni del 1896, rendendola un prezioso reperto che riflette i gusti artistici dell’epoca. Lo stile manierista, con le sue caratteristiche convenzioni stilistiche, colloca l’opera all’interno di un preciso movimento storico-artistico.
Sul lato sinistro della navata, la chiesa ospita anche una cappella dedicata a Sant’Eligio, vescovo di Noyon-Tournai 3. All’interno di questa cappella è conservato un dipinto raffigurante il santo. La presenza di una cappella dedicata a Sant’Eligio indica una particolare devozione verso questo santo all’interno della comunità di Butera, suggerendo un possibile legame storico o una particolare venerazione legata a specifiche tradizioni o professioni locali.
È importante chiarire che un triptych del XV secolo, dipinto su tavola e raffigurante San Tommaso Apostolo, San Pietro Apostolo, Maria Santissima delle Grazie e la Madonna degli Angeli 7, è situato nella Chiesa Madre di Butera, dedicata a San Tommaso, e non nella Chiesa Maria Santissima delle Grazie oggetto di questa analisi. Sebbene menzioni Maria Santissima delle Grazie, la sua ubicazione in un’altra chiesa esclude la sua inclusione tra le opere d’arte della chiesa qui descritta, a meno che non emergano ulteriori informazioni che ne attestino la presenza in entrambi gli edifici.
Infine, l’altare maggiore della Chiesa Maria Santissima delle Grazie è descritto come degno di nota 3. Presenta un rilievo centrale sul paliotto (la parte frontale dell’altare) raffigurante un drappeggio sul quale sono rappresentati i simboli della chiesa: una corona di dodici stelle con il logo mariano formato dalle lettere A ed M sovrapposte (iniziali di “Ave Maria”). Questi simboli mariani, esposti in modo prominente sull’altare maggiore, identificano chiaramente la dedicazione della chiesa alla Vergine Maria e costituiscono un elemento decorativo di significato simbolico e artistico.
- Significato Religioso e Culturale
La Chiesa Maria Santissima delle Grazie riveste un’importanza religiosa e culturale fondamentale per la comunità di Butera 5. La profonda devozione degli abitanti verso la Beata Vergine Maria, venerata con il titolo di Madre delle Grazie, si concentra principalmente in questa chiesa. Il titolo stesso sottolinea il ruolo della Vergine Maria come fonte di grazie e benedizioni divine per i fedeli. La festa annuale in suo onore, celebrata il 2 luglio, rappresenta un evento di primaria importanza sia dal punto di vista religioso che culturale per l’intera comunità. La costante enfasi sulla forte devozione mariana indica che la chiesa svolge un ruolo vitale nel plasmare l’identità religiosa e le pratiche spirituali degli abitanti di Butera.
La celebrazione annuale della Madonna delle Grazie è caratterizzata da una solenne novena che si svolge nei nove giorni precedenti la festa (dal 23 giugno al 1 luglio) 5. Durante questo periodo, la comunità si raccoglie in preghiera, recitando la “Coroncina” dedicata alla Madonna e partecipando alle celebrazioni eucaristiche presiedute da un predicatore appositamente invitato. Il giorno della festa, il 2 luglio, è scandito da numerose Sante Messe, culminando nella solenne processione serale della statua della Madonna attraverso il centro storico di Butera. La processione si conclude con uno spettacolo pirotecnico e la riposizione del simulacro nella sua nicchia sull’altare maggiore della chiesa. Questa articolata celebrazione, che include la novena, le messe e la grandiosa processione, dimostra il profondo impegno della comunità nell’onorare la propria patrona e la sua radicata integrazione nelle tradizioni culturali locali.
Durante i giorni della festa, a Butera viene recitata una preghiera tradizionale, una “Giaculatoria” 5. Questa breve e fervente orazione esprime la devozione della comunità verso la Madonna, invocando la sua grazia, la sua consolazione e, in particolare, il suo aiuto nell’ora finale della vita e durante le gravi infermità. L’esistenza di una preghiera specifica associata alla festa indica una tradizione secolare di ricerca del favore divino, del conforto e della protezione attraverso l’intercessione della Vergine Maria, specialmente nei momenti di bisogno e vulnerabilità. Questa preghiera funge da potente espressione della fede della comunità e della sua fiducia nella grazia della Madonna.
Il fatto che l’attuale Chiesa Maria Santissima delle Grazie sorga sul sito di una precedente chiesa medievale dedicata a Sant’Ippolito 1 suggerisce una continuità di spazio sacro e di significato religioso in questo luogo per secoli, aggiungendo uno strato di profondità storica alla sua attuale importanza religiosa per la comunità di Butera. Questa continuità sottolinea un legame spirituale profondo e duraturo per gli abitanti, che trascende la struttura attuale dell’edificio.
VII. Eventi e Festività Particolari
L’evento annuale più significativo legato alla Chiesa Maria Santissima delle Grazie a Butera è la Festa di Santa Maria delle Grazie, che si celebra il 2 luglio 5. La celebrazione include una solenne novena che si tiene dal 23 giugno al 1 luglio, una serie di Sante Messe il 2 luglio, con una particolare affluenza alla Messa solenne delle ore 11:00, e una grandiosa processione serale della statua attraverso il centro storico di Butera, che culmina con uno spettacolo pirotecnico e la riposizione del simulacro. Questo programma dettagliato evidenzia l’impegno organizzato e devoto della comunità nell’onorare la propria patrona.
Un altro evento religioso annuale di rilievo che si svolge presso la chiesa è rappresentato dalle celebrazioni pasquali 9. In particolare, la Domenica delle Palme vede una processione particolarmente suggestiva che rievoca l’ingresso di Gesù a Gerusalemme. Dopo la Messa, la processione del Santissimo Salvatore parte dalla chiesa e si snoda attraverso le campagne circostanti, accompagnata da dodici uomini vestiti come gli Apostoli, con la figura di Giuda volutamente caricaturale. Il fatto che le celebrazioni pasquali siano centrate sulla Chiesa Maria SS. delle Grazie sottolinea ulteriormente la sua importanza come sito religioso chiave a Butera. La processione della Domenica delle Palme, con i suoi figuranti in costume e la rievocazione simbolica, rappresenta una tradizione locale unica che fonde devozione religiosa, partecipazione comunitaria ed espressione culturale.
La seguente tabella riassume gli eventi e le festività annuali più importanti associate alla Chiesa Maria Santissima delle Grazie di Butera:
| Evento | Data(e) | Descrizione |
| Novena di Maria SS. delle Grazie | 23 giugno – 1 luglio | Nove giorni di preghiera e celebrazioni eucaristiche in preparazione alla festa patronale. |
| Festa di Maria SS. delle Grazie | 2 luglio | Sante Messe durante tutta la giornata, solenne processione serale della statua di Maria Santissima delle Grazie attraverso Butera, conclusione con spettacolo pirotecnico. |
| Domenica delle Palme (Pasqua) | Aprile (variabile) | Processione del Santissimo Salvatore che rievoca l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, con partenza dalla chiesa e coinvolgimento di membri della comunità in costume. |
VIII. Stato Attuale e Conservazione
Tra il 2007 e il 2010, la chiesa è stata oggetto di un significativo progetto di restauro 1. Questo intervento ha comportato lavori di consolidamento per rafforzare la struttura, una ristrutturazione generale dell’edificio e l’aggiornamento degli impianti interni. Inoltre, nel 2018, sono stati aggiunti un nuovo altare in legno e un ambone (leggio) all’arredamento della chiesa. Questi interventi dimostrano un impegno nella conservazione dell’integrità strutturale della chiesa e nell’aggiornamento dei suoi spazi liturgici. L’aggiunta del nuovo altare e dell’ambone suggerisce continui sforzi per mantenere la chiesa come un luogo di culto funzionale e rilevante.
Lo stato attuale della chiesa è descritto in dettaglio in una fonte del 2024 1. La descrizione conferma la pianta longitudinale con una singola navata, il presbiterio quadrato, la sua adiacenza ad altri edifici, la semplice facciata con conci di arenaria intagliata attorno al portale e una finestra rettangolare, le elevazioni secondarie intonacate con finestre rettangolari, le colonne interne che delimitano lo spazio per originariamente tre (ora una) cappelle laterali per lato, le superfici intonacate, la volta a botte lunettata con decorazioni in stucco, la cantoria in legno con un organo a canne e la pavimentazione in lastre di marmo Botticino e strisce di granito. Questa descrizione dettagliata conferma la continua esistenza della chiesa e fornisce un quadro delle sue caratteristiche fisiche e della sua disposizione attuale.
Un’altra fonte menziona la “Chiesa Madonna delle Grazie” a Butera insieme alla “Chiesa di Sant`Antonio” in un contesto che suggerisce che entrambe sono ancora esistenti e considerate punti di riferimento storici importanti all’interno della città 10. Questo rafforza l’idea che la chiesa sia attualmente in uno stato tale da meritare tale riconoscimento.
Tuttavia, le fonti consultate non contengono informazioni su eventuali progetti di conservazione in corso o pianificati oltre ai lavori di restauro completati tra il 2007 e il 2010 e alle aggiunte del 2018. Sebbene i precedenti sforzi di restauro siano documentati, l’assenza di menzione di progetti attuali o futuri nel materiale fornito non significa necessariamente che tali iniziative non siano in corso o in considerazione, ma queste informazioni non sono disponibili nell’ambito delle fonti di ricerca.
- Risorse Visive
Le fonti di ricerca fornite non contengono risorse visive dirette (immagini o tour virtuali) della Chiesa Maria Santissima delle Grazie a Butera 11. Alcune fonti menzionano celebrazioni parrocchiali a Butera 11 o tour virtuali di chiese con dedicazioni simili in altre località 12, ma non forniscono immagini specifiche della chiesa in questione. Anche le ricerche generiche di immagini per “Madonna delle Grazie” o “Santa Maria delle Grazie” 14 non mostrano specificamente la chiesa di Butera.
Tuttavia, una fonte menziona una “Galleria Fotografica” associata alla Festa di Maria delle Grazie a Butera 6. Questo suggerisce che potrebbe esistere una raccolta di immagini online relative alla chiesa, in particolare nel contesto della sua principale celebrazione annuale. Si raccomanda di effettuare ulteriori ricerche online specificamente mirate a “immagini Chiesa Maria Santissima delle Grazie Butera” e “tour virtuale Chiesa Maria Santissima delle Grazie Butera”, nonché di cercare la “Galleria Fotografica” menzionata, per ottenere risorse visive della chiesa.
- Conclusioni
La Chiesa Maria Santissima delle Grazie a Butera rappresenta un sito di notevole importanza storica, religiosa e culturale per la comunità locale. Le sue origini risalgono al XVI secolo, con una preesistenza medievale che ne sottolinea la lunga tradizione come luogo di culto. L’architettura esterna, caratterizzata da una facciata semplice ma con un portale in pietra arenaria di pregio, ha subito modifiche nel corso del tempo, con la recente rivelazione di una facciata in pietra durante i restauri che suggerisce un ritorno all’aspetto originario. L’interno, con la sua singola navata, la volta a botte lunettata decorata da stucchi e la pavimentazione in marmo e granito, ospita opere d’arte di significativo valore, tra cui il simulacro della Madonna delle Grazie attribuito a Vincenzo Genovese e un dipinto cinquecentesco della Madonna del cardellino.
La profonda devozione della comunità verso Maria Santissima delle Grazie si manifesta pienamente nella solenne festa annuale del 2 luglio, un evento che coinvolge l’intera città in celebrazioni religiose e processioni. La chiesa è anche al centro delle celebrazioni pasquali, evidenziando il suo ruolo centrale nella vita religiosa di Butera durante tutto l’anno. I recenti lavori di restauro testimoniano l’impegno nella conservazione di questo importante patrimonio. Sebbene le risorse visive dirette non siano state immediatamente disponibili, l’esistenza di una galleria fotografica legata alla festa patronale suggerisce la possibilità di reperire immagini online. Ulteriori ricerche mirate potrebbero fornire una visione più completa dell’aspetto attuale di questo significativo edificio religioso.